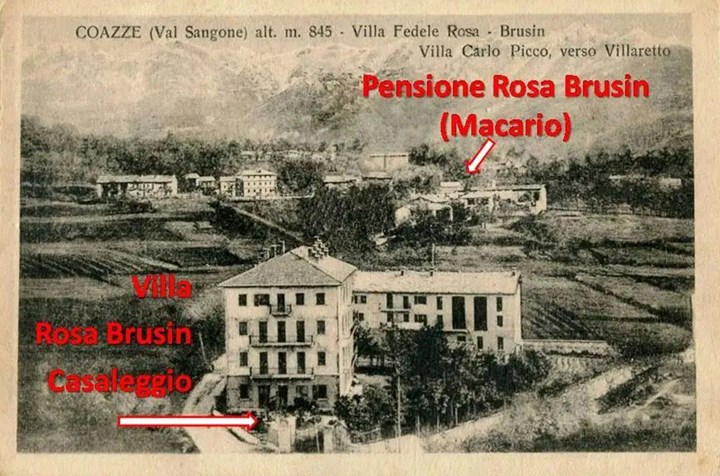Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo
La Val Sangone raccontata ai ragazzi... dalla bisnonna Livia Picco.
L'interno delle case/3
Vi invitiamo a curiosare dentro le case di montagna, per dare un’idea di come erano prima che la vegetazione selvatica le invadesse, rendendole impenetrabili, o le ristrutturazioni le trasformassero completamente.
La cucina
I locali più vissuti della casa erano la cucina e la stalla. In tre stagioni dell’anno (autunno, inverno, primavera) diventavano anche “salotto”, soggiorno e dormitorio.
Nella cucina spiccava il camino o, nelle case “più moderne”, la stufa. Nel camino una sbarra di ferro orizzontale reggeva le catene (cèńe) a cui si agganciavano i paioli, mentre sul fuoco o sulla brace si mettevano i treppiedi come appoggio per le casseruole e i tegami.
I camini di allora davano un senso di benessere quando erano accesi, ma avevano i loro limiti: disperdevano il calore nella canna fumaria e scaldavano solo nelle immediate vicinanze. La cucina inoltre si apriva direttamente sul cortile e l’andirivieni di una famiglia numerosa convogliava tantissima aria fredda.
Nella cucina si trovavano: il tavolo e le sedie (più o meno eleganti o malandati), dei ripiani di legno o una stagéra o un armadio a muro per i piatti e tutto il necessario per preparare i pasti. Le stagére e i ripiani erano ingentiliti da strisce di carta tagliuzzate con le forbici, per formare ingegnose decorazioni.
Sui tavoli della cucina hanno fatto i compiti generazioni e generazioni di scolari, spesso disturbati dal via vai dei famigliari, dagli strilli dei fratellini. Alle loro lamentele si sentivano rispondere: “Quando fai una cosa, pensa a quello che fai e non badare a tutto il resto”. Per un certo periodo, quando la bisnonna faceva i compiti ebbe il conforto di una calda presenza: un gattino rossiccio che faceva le fusa accovacciato sui piedi o sulla nuca, mentre lei si mordeva le dita sul problema “che non veniva” o sulle “trappole” della grammatica.
Nelle cucine non mancava la panca o la prìri, il muretto in pietra su cui si appoggiavano i secchi dell’acqua pulita per bere e cucinare, i paioli e le brùńse (pentole di ghisa).

La “brùńsa” appesa alla “cèńa” (catena), foto tratta da C’era una volta a Viù di Donatella Cane, Elena Guglielmino, Marilena Brunero.
Se neppure nei paesi c’era l’acqua in casa dappertutto, figuriamoci nelle borgate e nelle baite! Bisognava andare a prendere l’acqua alla sorgente, qualche volta lontana o in fondo a un prato ripido.
Si agganciavano i secchi al ba∫u, un’asta di legno leggermente incurvato, con due tacche alle estremità per i secchi, e si risaliva il sentiero, spesso ghiacciato o scivoloso, in equilibrio instabile, con un secchio colmo dietro la schiena e un altro davanti.
Per le necessità della famiglia non bastava un viaggio. Inoltre, per la maggior parte dell’anno, le bestie non andavano al pascolo e quindi bisognava portare l’acqua anche per loro. Per le mucche bere un secchio d’acqua è come per le persone berne un bicchiere. Che sollievo quando nella bella stagione bevevano al rio o all’abbeveratoio! La rivoluzione del gas in bombole e dell’acqua in casa arrivò alcuni anni dopo la guerra.
Dino Rege mostra come si portava il “bàsu” con i secchi.
La stalla, il fienile e la cantina
Le stalle erano in genere rettangolari con lo spazio ben ripartito. Sul lato più lungo stavano le mucche ed eventualmente le capre, legate alla greppia con delle catene. Sopra le greppia c’era la rastrelliera che veniva riempita di fieno e di erba mattino e sera.
Sul lato più corto stavano i vitelli. Sul lato lungo, parallelo a quello delle mucche, troneggiava il paiùń, un recinto di assi che tratteneva foglie secche ricoperte di paglia: serviva per riposare o anche come letto per tutta la famiglia negli inverni freddi. Le stanze erano gelide e di termosifoni neppure l’ombra!
Di fianco al paiùń c’era il salotto. Uno spazio tenuto pulitissimo con delle panche e degli sgabelli, vicino a una finestra o alla porta che aveva un finestrino incorporato. Nel soffitto sopra il salotto c’era un gancio per il lume a petrolio. D’inverno tutta la vita sociale delle borgate si concentrava in questo spazio. Infatti era il luogo dedicato alla “vià”.
LEGGI ANCHE: La “Vijà”, un momento di aggregazione che si svolgeva nelle stalle
C’erano stalle minuscole con una sola mucca e due o tre capre. Le pecore non stavano nella stalla ma in altro stanzone, perché la loro magnifica pelliccia “ecologica” teneva caldo come una stufa! E c’erano stalle grandi con quattro o cinque mucche. Lì si stava veramente bene anche nelle notti più rigide.
Piccola o grande che fosse la stalla, quando entrava uno sconosciuto gli animali lo squadravano con occhi indagatori. Tutti i musi si voltavano verso di lui.
Altri ambienti caratteristici erano i solai e la cantina (lu storn). Non bisogna pensare che essa contenesse file di bottiglie pregiate o damigiane panciute. Era il regno del latte e dei formaggi, delle patate e dei cibi, conservati nelle gabbietta appesa al soffitto, detta muschéra, l’antenata del frigo. In pochissime case soltanto, la cantina e le stalle avevano l’onore di un soffitto in muratura o di mattoni con le nervature, che convergevano al centro della volta ricurva.
I pavimenti al piano terreno erano di terra battuta (e quando pioveva tanto, qua e là si formavano pozzanghere da saltare sportivamente). Ai piani superiori pavimenti e soffitti erano fatti con assi di legno. Beate le persone che dormivano nella stanza sopra la cucina! Lì saliva un po’ di fumo, ma anche il tepore.
Sopra la stalle si trovava il fienile. Nel fienile c’era un buco, la tràpa, da cui si faceva scendere direttamente il fieno nella stalla. I ragazzi si divertivano a saltare giù dalla tràpa nel paiùń. Ma dagli adulti quante sgridate!
Le camere da letto
Curiosando, curiosando siamo arrivati alle camere da letto, poche per le famiglie numerose di quei tempi. In genere c’erano due stanze attrezzate con il lettone, un armadio, striminzito rispetto ai nostri armadioni, un tavolino e, qualche volta, i comodini.
Gli indumenti talvolta erano collocati su lunghe aste (pèrtie), appese orizzontalmente al soffitto.
Queste erano le stanze dei genitori e dei nonni. I ragazzi erano parcheggiati in camerette, fienili e stalla, a seconda dell’età e della stagione, le culle in camera dei genitori, i più grandicelli in un lettino in camera dei nonni o addirittura nel loro lettone.
Un particolare: i materassi di lana erano un lusso, molte volte si sostituivano con sacconi riempiti con foglie di faggio o di granoturco. Era la storica paiása o paiási. Se i bambini facevano la pipì a letto era molto più facile far asciugare o cambiare il contenuto del paiasòt.

Una camera da letto ormai in disuso (Foto di Bartolomeo Vanzetti)
Allora non esistevano i pannolini usa e getta e i piccoli, avvolti in fasce e quadrati di cotone o canapa, (le pàte), erano sempre bagnati.
I mobili, gli utensili della casa si tramandavano di padre in figlio e diventavano, talvolta, oggetto di liti accanite.
Da bambina la bisnonna ha sentito raccontare dai nonni che, in una borgata di montagna dell’Indiritto, due figli, alla morte del padre, si divisero l’eredità: le sedie, il tavolo, i paioli, le brùńse, le posate e le scodelle di legno. Sembrava che la divisione procedesse bene.
Alla fine restava l’armadio guardaroba. E lì scoppiò la guerra. Lo volevano tutti e due e non c’era verso di farli ragionare. Volarono insulti. Ciascuno gridò i propri meriti verso la famiglia, negati furiosamente dall’altro.
Erano sul punto di prendersi a botte, quando un parente, con ironia, suggerì: “Spaccatelo in due!”. Detto fatto. Afferrarono la sega e lo tagliarono a metà. E così giustizia fu fatta!
Particolari architettonici e costruttivi delle baite dell’alta Val Sangone

La colonna rotonda e la struttura a palancati che la sovrasta sono peculiari e rendono riconoscibile questo angolo rustico della Val Sangone.
Si tratta del famoso forno di Borgata Tonda dell’Indiritto di Coazze.
Molto più difficile scoprire dove si trovano i sottostanti particolari architettonici e costruttivi tipici delle antiche case della nostra valle, dove la pietra prevale sul legno.





Leggi anche:
LE ABITAZIONI DI UN TEMPO: 1 - LE CASE DEI PAESI
LE ABITAZIONI DI UN TEMPO: 2 - LE BORGATE MONTANE
In collaborazione con Guido Ostorero, Laboratorio Alte Valli propone alcuni estratti diLa Val Sangone raccontata ai ragazzi... dalla bisnonna Livia Picco, importante testimonianza sulla vita e sul lavoro delle nostre montagne: li trovate RAGGRUPPATI IN QUESTO LINK.
Per saperne di più vi rimandiamo al sito ScuolaGuido, su cui potete leggere l'articolo completo: Le case dei paesi e delle borgate